
È bastata una parola (“patriarcato”) pronunciata dalla sorella di una vittima di femminicidio per scatenare il putiferio. Nervo scoperto di un nemmeno tanto strisciante ritorno all’ordine, di una società divisa dalla volontà di predominio degli uomini, sempre sottotraccia per quanto sconfessata dai più.
Come donne, artiste, curatrici, critiche, intellettuali a più di cinquant’anni dai primi scritti delle studiose e attiviste femministe del dopoguerra quali Betty Friedan, Juliet Mitchell, Germaine Greer, la storica dell’arte Linda Nochlin e tante altre che hanno aperto nuovi orizzonti sul tema delle soggettività femminili, dobbiamo ancora ritenere “naturale” ciò che è null’altro che convenzionale, come affermava John Stuart Mill già nel 1869 nel suo esemplare pamphlet sulla sottomissione delle donne? Rispetto alle premesse di oltre cinquant’anni fa occorre chiederci: perché siamo ancora qui?

Le artiste, femministe e non
Non tutte le artiste sono femministe, non tutti i simpatizzanti sono donne. Donne si diventa, affermava Simone de Beauvoir, la madre di tutte noi, moltissimi anni fa. Il bersaglio della critica femminista non è oggi e non è mai stato i maschi in quanto tali, ma la cultura patriarcale che fa da piedistallo allo strapotere che gli uomini tuttora esercitano, e la perenne diminuzione della figura femminile ancora imperante sia nella cultura “alta” sia in quella popolare.
Come affrontare, dunque, un linguaggio che esclude, se non sfidandolo? La convenzione del nudo femminile, arrendevole e complice allo sguardo maschile viene demolita dalla body art già negli anni Sessanta con feroce ironia da molte artiste europee e statunitensi, oltre a un’agguerrita avanguardia giapponese. Nei suoi peep show, Yayoi Kusama, sdraiata con il corpo nudo decorato a pois, si offre quale oggetto delizioso al visitatore che scostando la tenda vede lei ma anche se stesso in mille rifrazioni allo specchio, obbligato suo malgrado ad affrontare il proprio voyeurismo.
La body art, alla quale Lea Vergine ha dedicato un saggio nel 1974, è stata importante perché rende esplicita l’intersoggettività, ossia la relazione intercorporea tra le persone, ponendo al centro dell’attenzione la dimensione performativa, il corpo in azione, una dimensione dell’arte che accomuna gran parte dell’umanità in tutto il mondo.

L’arte di Jenny Saville e Carla Lonzi
Utilizzare il proprio corpo come forma d’arte vuol dire collassare soggetto e oggetto, un’operazione che rivela l’angosciosa necessità di gridare la propria diversità non riconosciuta. Ricordiamo l’immagine di Hanna Wilke, il suo bellissimo volto sfigurato da piccoli chewing gum, nella forma di tante mini vulve. Il titolo dell’opera è S.O.S. una disperata richiesta di aiuto, (Starification Object Series), 1974.
Ci vuole tutta l’energia di una figura eroica come Jenny Saville per affrontare, dall’interno della convenzione pittorica occidentale, il tema dell’ambiguità dei corpi: magnifici, imponenti, lacerati, doloranti, dalle identità plurali, dal genere ambiguo, come nel dipinto intitolato Passage (2004). Studiose femministe quali Iris Marion Young, Judith Butler e persino Martha Nussbaum teorizzano una riconcettualizzazione del corpo, in cui il vecchio slogan “Il personale è politico” acquista nuovo significato. Fino ad arrivare all’inclusione dei corpi ritenuti un tempo abietti, i corpi dello scandalo, espulsi dal linguaggio, oggetto di tabù, irrappresentabili, oggi finalmente ammessi nella sfera pubblica. Il corpo queer viene risignificato, riappropriato, normalizzato, disinnescando il ribrezzo e rendendo visibile il dolore, come in alcuni lavori di Kiki Smith oppure di Mike Kelley.
E in Italia? La questione femminile fatica a emergere nel dibattito pubblico. Persino Carla Lonzi, femminista e storica dell’arte, rimane isolata, inascoltata, senza interlocutori tra i pensatori, poeti ed intellettuali dell’epoca, se non come intervistatrice degli artisti suoi coetanei cui dà la parola nel celebre Autoritratto (1969) tra i quali c’è una sola donna, Carla Accardi. Nel dare la parola direttamente agli artisti, compie un lavoro ermeneutico assolutamente inedito che segna una svolta che supera finalmente la finzione di un “io” universale, sempre declinato al maschile. Lonzi non lo sostituisce con un pensiero al contrario, binario, ma con un’apertura a soggettività diverse collocabili nel qui ed ora. Del resto, come ha scritto nel 2011 Michela Murgia in un saggio poco conosciuto intitolato Ave Mary. E la Chiesa inventò la donna, non c’è da meravigliarsi se in Italia le donne si siano affermate con un notevole ritardo, oscurate per secoli dall’immagine femminile per eccellenza, quella della mater dolorosa, per definizione passiva, potenziale vittima, soprattutto madre, mai padrona del proprio destino.
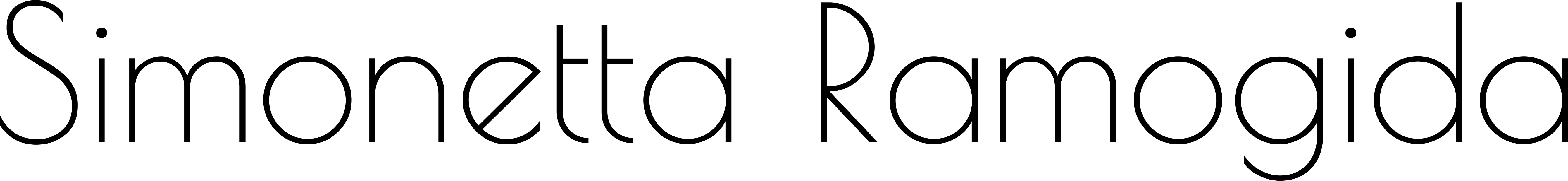





Devi effettuare l'accesso per postare un commento.